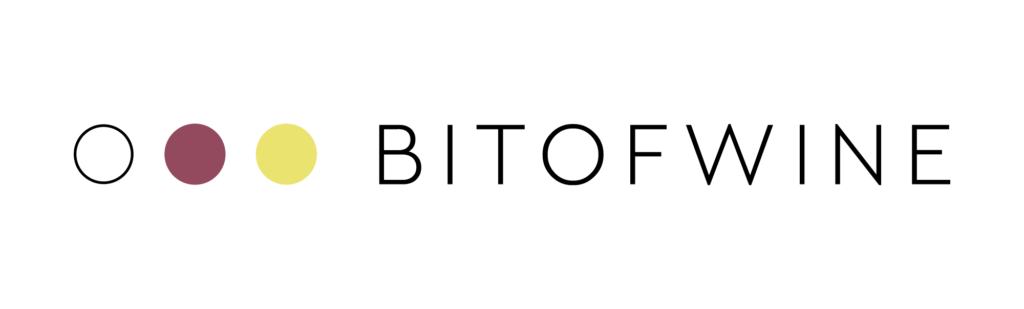L’etichetta sulle bottiglie di vino è spesso una piccola opera artistica, ma non serve solo a riconoscere un vino a colpo d’occhio. Contiene, anzi, preziose informazioni che possono aiutarti a capire molto meglio il vino che stai per bere e le sue caratteristiche.
Non sai da dove iniziare? Leggi questo articolo su come leggere l’etichetta di un vino: ti guideremo attraverso le sue varie parti, aiutandoti a valutare meglio qualsiasi bottiglia.
Etichetta dei vini: come leggerla e cosa guardare?
In pochi centimetri quadrati di carta, l’etichetta di una bottiglia di vino racchiude molte preziose informazioni sul vino stesso. Imparare a decifrare queste informazioni è la base per imparare, passo dopo passo, a conoscere meglio i vini e a fare scelte enologiche sempre più consapevoli.
Hai ricevuto in regalo una bottiglia di vino, o devi acquistarne una, e vuoi capire che caratteristiche ha? Inizia dall’etichetta!
Ecco quali sono le informazioni da ricercare a da leggere con attenzione per recepire le giuste informazioni.
Nota di Mr. Bit
Mi scuso per l’intromissione in questo articolo, ma…se devi fare un ottimo regalo ad un appassionato di vino, ho creato una pagina apposta dove puoi trovare anche gli astucciati, ti consiglio di dargli una occhiata, la trovi qui -> Idee regalo per chi ama il vino.
1 – Nome del vino
Indubbiamente, il nome del vino è molto spesso l’elemento più grande e vistoso dell’etichetta, quello che per primo cattura l’attenzione. Decifrare il nome di un vino è un po’ come giocare a fare il detective, cercando di scoprire se le parole utilizzate nascondono un significato più o meno implicito.
A volte, il nome del vino è molto chiaro, perché si riferisce a un vitigno ben preciso, oppure a una specifica zona di produzione.
Il nome può:
- essere costituito semplicemente dalla varietà di uva ( come ad esempio il “Nebbiolo” -> scopri qui tutti i nostri Vini a base di Nebbiolo”);fornire indicazioni sulla regione vinicola in cui il vino è stato realizzato (“Etna”);
- essere un nome proprio scelto dai produttori: anche in questo caso, può trattarsi di un nome puramente di fantasia;
- derivare da qualche elemento del mondo del vino che vale la pena di essere esplorato. Un vino rosso della cantina veneta Tommasi, ad esempio, si chiama Arele perché “arele” è il nome degli antichi graticci in legno e bambù su cui le uve vengono lasciate ad appassire.
2 – Nome del produttore
L’azienda vinicola che ha prodotto il vino è a volte il primo elemento che si va a guardare. Perché? Beh, perché certe aziende vinicole sono molto rinomate, e note per produrre vini di qualità in modo costante. Chi conosce il nome di quel produttore e lo ha apprezzato in passato, tenderà a controllare subito chi ha prodotto il vino per essere certi della qualità.
Anche se non li hai mai provati, ci sono produttori come Frescobaldi, Antinori, Ornellaia, Gaja (e moltissimi altri) che sono sinonimo di eccellenza nel settore vinicolo italiano. A volte basta ricercare nomi come questi per assicurarsi di stare per bere un buon vino o di regalare una bottiglia che sarà sinceramente apprezzata.
Nonostante ciò, chi vuole conoscere meglio il vino è quasi “moralmente obbligato” a esplorare cantine nuove e diverse, ricercando ogni volta l’eccellenza in posti sconosciuti o in piccole realtà a conduzione familiare. Dalle piccole aziende vinicole nascono spesso vini di eccellente qualità, che sarebbe un peccato non provare solo perché il produttore non è rinomato.
3 – Annata
Sulla parte frontale dell’etichetta, insieme a nome del vino e nome del produttore, vedrai sicuramente un anno. Si tratta della cosiddetta annata, ovvero l’anno in cui sono state raccolte le uve per produrre quel vino. È un dato fondamentale per capire la qualità del vino, dato che essa può variare notevolmente da un’annata all’altra. Uno stesso identico vino, prodotto dalla stessa cantina ma in due annate diverse, può presentare caratteristiche organolettiche differenti.
Un’annata può essere più o meno buona in base a diversi fattori:
- condizioni climatiche nel corso dell’anno, prima e durante il periodo di vendemmia;
- temperatura, umidità o secchezza dell’aria;
- giorni di pioggia e abbondanza di precipitazioni;
- presenza di elementi come vento forte, pioggia o neve…
Un esempio di annata particolarmente interessante in Italia per il vino è stato il 2016: in quell’anno, le condizioni climatiche generali su tutte le regioni vinicole italiane hanno fatto sì che le uve raggiungessero il punto di maturazione ideale per la vinificazione (leggi anche: Come si fa il Vino? Il processo di vinificazione).

4 – Eventuale denominazione
Quando si impara a leggere l’etichetta di un vino, la denominazione acquista naturalmente una certa importanza. Se sull’etichetta è presente una denominazione, puoi essere sicuro che si tratta di un vino di alta qualità.
In Italia, le denominazioni per il vino sono:
- DOC (Denominazione di Origine Controllata);
- DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita);
- DOP (Denominazione di Origine Protetta);
- IGT (Indicazione Geografica Tipica)
- IGP (Denominazione Geografica Protetta).
Esistono denominazioni (o appellations) anche in altri Paesi a forte vocazione vinicola, come AOC e AOP in Francia.
Le denominazioni sono importanti da ritrovare sull’etichetta di un vino perché sono veri e propri sigilli di qualità.
Garantiscono che:
- il vino provenga da una determinata regione vinicola;
- sia stato prodotto secondo regole precise;
- siano stati mantenuti tutti i più elevati standard di produzione e qualità.
5 – Gradazione alcolica (titolo alcolometrico)
Questo piccolo numero, espresso in percentuale sul totale del volume (% vol.), indica la presenza di alcol nel vino. Ad esempio, “12% vol” significa che una dodicesima parte del totale volumetrico del vino è composta da alcol etilico. La maggior parte dei vini contiene una percentuale di alcol tra l’11 e il 14%, con differenze anche significative tra vini bianchi e vini rossi.
I vini rossi tendono spesso ad avere una gradazione alcolica più alta, anche se solo in linea generale.
Oltre a comunicarti quanto alcol ingerirai bevendo un bicchiere di quel vino, la gradazione alcolica fornisce soprattutto informazioni preziose su sapore, corpo e struttura del vino. Una gradazione alcolica bassa indica infatti un vino non troppo corposo e strutturato, quindi più leggero e facile da bere. Con una gradazione più alta, il vino tende a essere più corposo e persistente in bocca. Come abbiamo visto nella guida completa al vino rosso oppure nella guida al vino bianco, infatti, la gradazione alcolica è uno degli elementi che concorre al concetto di struttura in un vino.
6 – Volume
Il volume indica semplicemente la “grandezza” della bottiglia, ovvero la quantità di vino all’interno del contenitore. Questa grandezza si misura generalmente in millilitri (ml), litri (l) o centilitri (cl). Quando il vino è commercializzato in Europa, in seguito al volume deve essere presente il simbolo e.
La bottiglia di vino standard più comune in assoluto è la bordolese, con un volume di 750 millilitri (tre quarti di un litro). È comunque possibile trovare diversi volumi, come la mezza bottiglia (375 millilitri) o formati più grandi come la famosa “magnum”, da un litro e mezzo.
7 – Varietà di uva
Quando si legge l’etichetta di un vino, a volte si possono trovare indicazioni anche sulla varietà dell’uva utilizzata per produrre il vino stesso. Inserire questa informazione sta diventando sempre più comune specialmente tra i produttori provenienti dai Paesi entrati nel mondo enologico più di recente, come Australia e Stati Uniti.
Conoscere le varietà di uva utilizzate è importantissimo per prevedere il gusto che avrà il vino, facendo quindi scelte più consapevoli e più coerenti al proprio gusto personale. Se la varietà di uva è ad esempio Cabernet Sauvignon al 100%, saprai che il vino che hai tra le mani sarà discretamente tannico e astringente. Molto spesso i vini sono poi il risultato di un assemblaggio di uve di diverse varietà: se questa informazione è presente e se conosci le caratteristiche tipiche dei diversi vitigni, ti sarà più facile sapere cosa aspettarti dalla degustazione di quel vino.
8 – Loghi specifici
Insieme al nome, naturalmente la cantina desidera inserire il proprio logo nell’etichetta. Oltre a questo, in alcuni vini potrebbero essere presenti anche dei loghi che sono simbolo di categorie specifiche di vino. Ciò accade, ad esempio, nel caso di vini biologici, vini biodinamici o vini naturali.
9 – Note di degustazione
Sul retro della bottiglia, le “controetichette” di alcuni vini contengono preziose informazioni su aspetto visivo, sentori e sapori che si possono generalmente riconoscere in quel vino. Questi dettagli sono molto importanti specialmente per chi non ha ancora una grande dimestichezza con il vino, poiché è come se gettassero le basi per una vera e propria degustazione guidata. Se vuoi imparare a degustare meglio il vino, puoi analizzare queste etichette e farti accompagnare nella ricerca di aromi e sapori.
Informazioni di questo tipo sono anche utili per capire se il vino in oggetto potrà essere di nostro gradimento. Se, ad esempio, non amiamo le note speziate dei vini ma le ritroviamo nelle informazioni dell’etichetta, sapremo già che forse quel vino non sarà perfettamente nelle nostre corde.

10 – Consigli sugli abbinamenti
Specialmente sui vini pensati per il largo consumo, ma non prodotti in modalità industriale, alcune etichette recano informazioni su come abbinare quel vino al cibo. Ricercare queste informazioni può essere davvero utile per chi si approccia da poco al mondo del vino: fanno capire meglio se vale la pena acquistarlo per essere aperto o regalato in occasioni in cui si sa che a tavola ci saranno specifiche pietanze.
11 – Consigli sul servizio
Un’altra informazione che i neofiti del vino (ma non solo!) potranno trovare molto utile in alcune etichette riguarda le indicazioni sulle modalità di servizio. Queste indicazioni cercano di aiutare chi beve il vino a fare tutto ciò che è necessario per apprezzarlo al meglio.
Si può trovare ad esempio:
- temperatura consigliata di servizio;
- tipologia di calice ideale relativamente al quel vino;
- le più indicate modalità di conservazione.
Cosa deve contenere l’etichetta di un vino?
Nonostante le etichette dei vini possano recare parecchie informazioni, sono solo alcune quelle obbligatorie per legge. In accordo con i regolamenti dell’Unione Europea, in Italia queste diciture sono:
- nome della cantina vinicola produttrice ed eventualmente dell’imbottigliatore (quest’ultimo va inserito solo se diverso dal produttore. A volte, per questioni di brevità, si utilizza la dicitura ICQFR – Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi – seguita dal comune di provenienza dell’azienda imbottigliatrice);
- annata (che non deve però essere presente nei comuni vini da tavola);
- denominazione di origine o denominazione di vendita (in grande se si tratta di una denominazione come DOC, DOCG o IGT; anche in piccolo se si tratta di denominazioni generiche come “vino bianco”, “vino rosso”, “vino frizzante” o “vino rosato”);
- gradazione alcolica;
- volume;
- avvertenze sanitarie (ad esempio, la presenza di solfiti e altri allergeni. Essendo i solfiti presenti in piccole quantità in maniera naturale nel vino, il produttore non è tenuto a specificarne la presenza se inferiore ai 10 mg/l);
- lotto di produzione (indica le bottiglie prodotte e/o confezionate nello stesso momento e luogo, garantendo quindi la tracciabilità del prodotto);
- dicitura “prodotto in Italia” (in generale, il Paese di provenienza deve essere sempre presente per legge su ogni etichetta).
Come capire se un vino è buono dall’etichetta
L’etichetta rappresenta sicuramente una sorta di carta d’identità del vino, contenendo tutte le informazioni essenziali che lo riguardano. Non riesce naturalmente a comunicare se un vino è “buono”, ma rappresenta comunque un ottimo punto di partenza per reperire maggiori informazioni sul vino così da conoscerlo meglio.
Per capire se il vino è buono è possibile approfondire online, partendo dall’etichetta. Si potrebbero cercare:
- il nome del produttore e leggere opinioni, recensioni e valutazioni in merito;
- l’anno di vendemmia e vedere se si tratta in generale di un’annata buona per la zona di produzione di quel vino;
- le caratteristiche del vitigno (Vermentino, Chardonnay…) o del tipo di vino (Barolo, Brunello di Montalcino…) per capire se i loro aromi e sapori tipici possono essere di tuo gradimento.
- informazioni più approfondite proprio sul vino in questione, affidandoti a esperti come enologi e sommelier (anche online) che ne descrivano le proprietà e qualità.
I consigli di Mr. Bit
Sapevi che anche noi di Bit Of Wine possiamo essere un’ottima fonte di informazioni sui vini?
A partire dall’etichetta, puoi ricercare il nome del vino e scoprire tutto ciò che ti serve sapere. Per ogni vino che proponiamo è presente una scheda che elenca, tra le altre cose, i vitigni impiegati, i sentori e sapori alla degustazione, nonché gli abbinamenti consigliati.
Informazioni facoltative su vini di specifica qualità
Nel caso di alcuni vini DOC o DOCG, è possibile (ma non obbligatorio) includere delle diciture che comunichino delle caratteristiche ben precise del vino.
Queste caratteristiche sono solitamente “positive” e indice di alta qualità, perciò i produttori non esitano mai a inserirle quando i loro vini ne soddisfano i requisiti necessari. Se stai imparando a leggere l’etichetta del vino, queste diciture sono appunto utili per valutarne meglio la qualità, e rappresentano anche la scelta ideale per avviare una propria collezione di vini.
Etichetta con: Riserva.
Un vino è Riserva se è stato sottoposto a un periodo di affinamento più prolungato rispetto al normale processo di invecchiamento della stessa tipologia di vino.
Per raggiungere questo livello, il periodo di affinamento deve essere:
- minimo due anni per i vini rossi;
- un anno per i vini bianchi o i vini spumanti metodo Charmat o Martinotti;
- tre anni per i vini spumanti a rifermentazione naturale in bottiglia.
Etichetta con: Superiore.
Rispetto a una sua controparte non Superiore, il vino che vanta questa dicitura ha una gradazione alcolica leggermente più alta (solitamente, intorno allo 0,5% vol.). Questo avviene perché il vino è stato prodotto da uva maturata in condizioni climatiche più favorevoli e, quindi con un più alto quantitativo di zuccheri che si trasforma in un più alto quantitativo di alcol.
Etichetta con: Classico.
Quando un vino è Classico, significa che è stato prodotto da uve coltivate nella zona originaria e più antica nella circoscrizione del territorio in cui quella DOC o DOCG può essere prodotto.
Quando la denominazione è stata assegnata, infatti, il territorio a cui si applicava era limitato ma, col passare del tempo, spesso capita che si estenda a diversi comuni limitrofi. Quindi, se un Chianti o un Amarone possono essere prodotti in tutto il territorio della denominazione attuale in Chianti e Valpolicella, quelli prodotti esclusivamente nelle zone della denominazione originale diventeranno Chianti Classico e Amarone Classico.